Nelle intenzioni della Fondazione e mie, sin dall’inizio era ben chiara una cosa: […] bisognava affrontare l’opera artistica di Fava da una diversa prospettiva. E più studiavo i suoi quadri, le sue incisioni, i suoi disegni, più leggevo la sua letteratura, più ascoltavo le sue trasmissioni radiofoniche, più mi convincevo del fatto che di lui fino ad oggi conoscevamo e piangevamo quasi esclusivamente la figura dell’intellettuale militante contro la mafia. Per ragioni contingenti e oltremodo necessarie, dal 1984 fino ad oggi la sua iconografia e iconologia si era consolidata nel tipo dell’eroe civile, al pari dei martiri che nell’Italia meridionale e nella Sicilia dell’ultimo trentennio del Novecento erano stati sterminati dalle cosche mafiose e dai sistemi politico-affaristici. Una dimensione tragica che ha finito per riflettersi nel codice narrativo usato per dettagliare fino a oggi la sua produzione artistica. Ma Giuseppe Fava era un palinsesto, depositario di moltissimi altri valori che a mio avviso – mi andavo convincendo – attendevano di essere messi nel giusto risalto affinché emergesse in tutta la sua pienezza la figura dell’intellettuale che partecipa da protagonista alla Storia dell’Italia contemporanea. Per fare questo, era a mio avviso necessario riprendere il discorso dal profondo vitalismo che albergava in tutto ciò che egli fece, il grande amore per la vita, per la gente comune, per i paesaggi, per il cibo, per il buon vivere, tutti aspetti che, assieme alla pratica dell’inchiesta e della denuncia, ebbero un posto di grandissimo rilievo nella sua vita e che invadono continuamente la scena.
Questa è la ragione per cui ho costruito la mostra come un dramma tragico secondo il canone greco: con un prologo, un parodo, quattro episodi, tre stasimi, un’invocazione e un esodo. I puristi della tradizione classica storceranno il naso, ma è pur sempre un’interpretazione nel contemporaneo e penso che essa calzi a pennello per fare sintesi di una così complessa vicenda. I raggruppamenti di opere che ho scelto, tuttavia, non corrispondono (almeno questa è l’intenzione) all’oleografia neorealista cui ci eravamo abituati, gravitante tutta intorno alle dicotomie basso-alto, potere agito-potere subito, mafia-denuncia; essi cercano, a loro modo, sentieri narrativi differenti: l’infanzia e i primi interessi per il disegno, la definizione di una precisa maniera espressiva, la centralità delle donne, la passione per la gente comune nello spazio dell’urbe, l’amore per il paesaggio agrario e marinaresco (con il suo cibo, i suoi odori, i suoi sapori), l’eredità culturale che egli ci tramanda. Molte delle opere in mostra sono conosciute e hanno una breve ma significativa fortuna critica ed espositiva; molte altre, per le ragioni pocanzi accennate, sono poco note o del tutto inedite. La combinazione di questi due fattori (la sintassi ‘nuova’ della mostra, la novità di alcune tra le opere esposte, la forma compendiaria che ha assunto il catalogo) vorrebbe contribuire al riposizionamento di Giuseppe Fava nell’alveo dei più grandi intellettuali italiani del secondo dopoguerra.
Vittorio Ugo Vicari
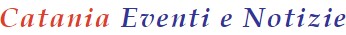 Catania Eventi e Notizie
Catania Eventi e Notizie














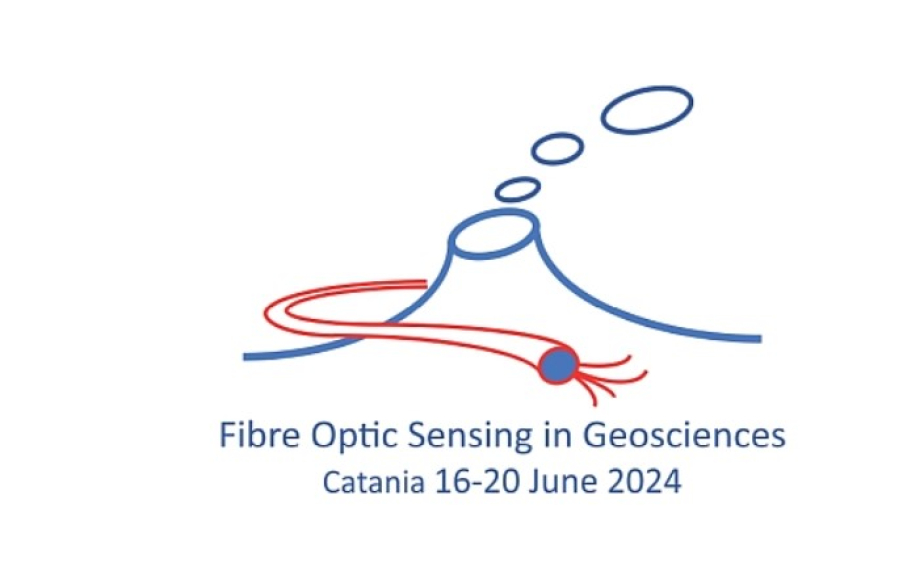 Conferenza Fibre Optic Sensing in Geosciences
Conferenza Fibre Optic Sensing in Geosciences  58° Meeting CapTech
58° Meeting CapTech  Canta e Cunta | Festival delle Tradizioni Siciliane
Canta e Cunta | Festival delle Tradizioni Siciliane 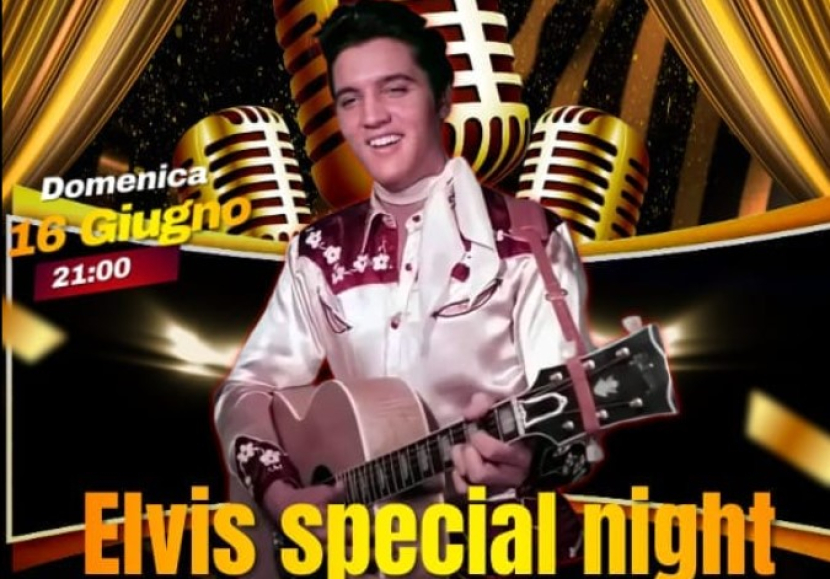 Elvis Special Night - Movie Edition
Elvis Special Night - Movie Edition  La Grande Traversata dell'Etna
La Grande Traversata dell'Etna